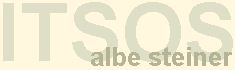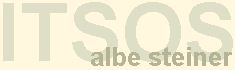VERSO
UN CURRICOLO RETICOLARE (a cura di Nicola Scognamiglio).
LE
CARATTERISTICHE DELLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE.
Tre dovrebbero essere
le caratteristiche principali che caratterizzano la programmazione curricolare
di Geostoria:
1. Pensare all'insegnamento
della Storia inserito in un'area a se stante, quella storico/sociale,
al fine di interrompere il tradizionale (e oggi non più sostenibile)
abbinamento delle discipline storiche con quelle linguistico-letterarie
(con la conseguente contrapposizione tra cultura umanistico-letteraria
e cultura sceintifico-matematico-naturalistica).
2. il curricolo reticolare,
con le seguenti caratteristiche di fondo:
-
sul piano storiografico assume
quale angolazione prospettica privilegiata la Storia Contemporanea (XIX°
e XX secolo).
-
sul piano didattico, e più
precisamente sul piano dei criteri di organizzazione dei contenuti, si
sposta dall’impianto a moduli, verso un impianto a rete, procedendo
dalle maglie più larghe a quelle più fitte. Ciò significa
che la scelta e il criterio degli argomenti inseriti nel curricolo seguiranno
tre condizioni:
A. gli argomenti iniziali saranno quelli che comportano un numero relativamente
ristretto di concetti-chiave (i temi a maglie larghe) e quindi più
semplici, ad esempio l’U.D.B sulle diverse proiezioni cartografiche; gli
ultimi argomenti saranno i più complessi e saranno quelli che richiedono
un maggior numero di concetti-chiave (i temi a maglie più fitte)
ad esempio i “recenti” processi di mondializzazione.
B. rispetto al problema delle scale spaziali, per quanto l’impostazione
sia particolarmente vicina alla World History, si farà attenzione
a presentare dei diversi argomenti una pluralità di scale, passando
da quelle planetarie, a quelle europee e soprattutto nazionali.
C. Anche per quanto riguarda la questione delle scale temporali, si privilegeranno
argomenti legati a dinamiche di lunga durata, argomenti intesi come
cornici, che renderanno possibili approfondimenti (spesso di tipo laboratoriali)
su temi e sotto-temi di durata più breve. In particolare il metodo
(favorito anche dal particolare libro di testo) si fonderà sulla
presentazione di un argomento osservato nelle sue linee generali nel presente,
studiato alle sue origini e nel suo svolgersi nel passato, pensato, attraverso
momenti di riflessione, per quanto riguarda il futuro. In questo modo si
eviterà il rischio che lo studio della Storia Contemporanea sia
inteso come studio del presente, cioè si eviterà il rischio
di scadere nell’eventografia, se non addirittura nella cronaca.
3. Il laboratorio
di storia, individuato come momento indispensabile e qualificante all’interno
dell’attività curricolare.
Una sperimentazione dell’insegnamento
della storia che fa quindi regolarmente ricorso (non in modo straordinario
) ad attività laboratoriali tese a favorire – attraverso tecniche
didattiche di tipo costruttivista – un apprendimento della storia
basato non solo attraverso la conoscenza dei fatti e degli avvenimenti,
ma soprattutto grazie ad un operare in prima persona da parte degli studenti
sia attraverso il metodo della ricerca didattica che della didattica per
progetti.
FINALITA’
GENERALI
-
Acquisire una coscienza democratica
(nodi 2 e 4).
-
Acquisire consapevolezza
dei propri diritti/doveri (nodi 2, 3 e 4).
-
Sviluppare una forma mentis
inteculturale (nodi 1, 2, 3 e 4).
-
Sapersi orientare storicamente
nel presente, conoscendone i principali nodi problematici e sapendone individuare
la genesi nel corso della storia contemporanea.
OBIETTIVI
Lo studente alla fine del
biennio dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi,
abilità, competenze e concetti
1.
Relativi al testo
1.1
ricavare da un testo le informazioni richieste in base ad una domanda e
ad un
problema
1.2
leggere e comprendere testi complessi
1.3
leggere grafici, tabelle, carte geografiche, carte tematiche, ecc.
1.4
utilizzare e produrre grafici, tabelle, carte geografiche, carte tematiche,
ecc.
1.5
schematizzare graficamente un testo evidenziandone la struttura logica
1.6
distinguere i fatti dalle interpretazioni
1.7
conoscere le diverse tipologie testuali, attraverso la lettura e
il confronto
1.8
saper fare del proprio lavoro un’esposizione organica sia orale che scritta
2.
Relativi al tempo
2.1
distinguere i diversi modi di misurare il tempo storico (cronologie, periodizzazioni,
ecc.)
2.2
individuare priorità, posteriorità e contemporaneità
negli eventi
2.3
distinguere gli avvenimenti in base alla loro relazione col tempo (mutamenti,
persistenze)
2.4
cogliere i mutamenti a partire da una situazione iniziale
2.5
confrontare tra loro due fenomeni collocati in ambiti temporali differenti
2.6
collocare correttamente nel tempo i fenomeni studiati
2.7
collocare avvenimenti in successione cronologica
2.8
distinguere le varie durate nei fenomeni
2.9
riconoscere forme di periodizzazione
3.
Relativi allo spazio
3.1
distinguere e collegare i fattori storici e quelli geografici in un fenomeno
dato
3.2
confrontare tra loro due fenomeni collocati in ambiti spaziali differenti
3.3
leggere e utilizzare carte, mappe, planisferi
3.4
comprendere la simbologia cartografica (tassonomia geografica)
3.5
confrontare e utilizzare i diversi tipi di proiezione cartografica (Mercatore,
Peters, ecc.)
3.6
distinguere i concetti di spazio, luogo, suolo, ambiente territorio, paesaggio,
ecc.,
rispetto all’uso indiscriminato di tali concetti geografici nella pubblicistica
corrente
3.7
leggere, utilizzare e costruire carte tematiche appropriate rispetto alla
rappresentazione di alcuni fenomeni
3.8
osservare e comprendere la distribuzione spaziale, lo sviluppo, la causalità,
la
casualità, la connessione e l’interdipendenza di un fenomeno
3.9
collocare correttamente nello spazio i fenomeni studiati
4.
Relativi alla terminologia, ai concetti e alle interpretazioni
4.1
acquisire una appropriata competenza terminologica sia storica che geografica
4.2
descrivere i fenomeni studiati utilizzando la terminologia appropriata
4.3
conoscere i concetti ordinatori disciplinari (causa, effetto, periodizzazione,
continuità, durata, mutamento, ciclo, contemporaneità, relazione,
ecc.)
4.4
cogliere i nessi causa-effetto
4.5
conoscere i concetti interpretativi disciplinari
4.6
conoscere i diversi tipi di fonti
4.7
saper interrogare le fonti
4.8
porsi domande e formulare ipotesi
4.9 confrontare
diverse interpretazioni di un fenomeno
4.10 essere
consapevole e stabilire relazioni tra fatti storici, storia e storia personale
4.11 comprendere
le relazioni tra situazioni ambientali, culturali ed economiche
4.12 comprendere
la necessità dell’intreccio interdisciplinare per la comprensione
dei
fenomeni storici e geografici
5.
Relativi alla metodologia
5.1
Saper ascoltare
5.2
Rispettare tempi e consegne di lavoro
5.3
Saper comunicare con gli altri
5.4
Sentirsi parte di un gruppo
5.5 Saper
tenere in giusta considerazione i contributi e gli interventi provenienti
dagli
altri componenti
del gruppo
5.6 Individuare
e calibrare i propri interventi in relazione al lavoro complessivo
5.7 Saper
mettere in atto capacità di mediazione
5.8 Utilizzare
nei modi adeguati gli strumenti di lavoro (libri, atlanti, filmati, appunti,
immagini, testimonianze,
documenti, ecc.)
5.9 Riconoscere
e impiegare correttamente le diverse fonti e i diversi documenti
5.10 Intraprendere
un corretto percorso di ricerca
5.11 Saper
essere autonomi e intraprendenti nel lavoro
5.12 Comprendere
ed usare i linguaggi e gli strumenti specifici
I
NODI DELLA STORIA CONTEMPORANEA
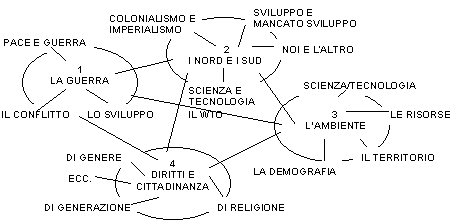
A mio avviso partendo da
questi quattro nodi si può procedere ad individuare le unità
di lavoro che compongono il curricolo a rete.
LE
PRINCIPALI STRATEGIE DIDATTICHE
All’inizio di ogni
unità verranno esplicitati contenuti, attività e tipo di
verifica.
Le ore curricolari,
vedranno alternarsi momenti di esercitazioni pratiche individuali e di
gruppo, a lezioni frontali tese ad introdurre, presentare, puntualizzare
gli argomenti in esame.
Verrà
stimolata, in particolare, l’operatività dei ragazzi tramite ricerche
e ipotesi di lavoro, esercitazioni cartografiche, analisi di dati
statistici, ricerche su immagini, testi ed altre diverse fonti.
In particolare verrà
incoraggiata la capacità di comprendere relazioni tra situazioni
ambientali, economiche culturali e sociali, in stretta connessione
con il corso di Storia ed il corso di educazione
linguistica relativamente ai diversi argomenti trattati e all’area di progetto.
Sarà pertanto
spesso richiesto ai ragazzi di ricercare ed analizzare dati, formulare
ipotesi e verificarle, tramite un frequente addestramento ad un uso non
lineare del testo in adozione, all'utilizzo di modelli di analisi.
Particolare attenzione
verrà data al lavoro di gruppo al fine di abituare gli studenti,
grazie alle tecniche messe in atto attraverso il lavoro cooperativo e collaborativo,
di esercitare e raggiungere i principali obiettivi già menzionati
al paragrafo 5 .
Durante le lezioni
frontali si farà ricorso, in modo frequente, alla tecnica del brainstorming,
alla creazione collettiva e individuale di mappe congnitive (mappe ingenue)
e di mappe concettuali (mappe esperte), all’uso dei frame e degli script.
Una unità di
lavoro (o più) sarà realizzata attraverso la didattica per
progetti.
VALUTAZIONE
E VERIFICHE
Diverse saranno le modalità
di verifica e di valutazione: interrogazioni orali, test, verifiche scritte
strutturate e semi strutturate, confronti dialogati (discussione) sui risultati
di un’attività, comunicazione degli esiti di un percorso di ricerca
ad interlocutori esterni anche mediante la produzione di materiali (sito,
interviste, ecc.), ricostruzione delle modalità che hanno guidato
un percorso di ricerca (riflessione di tipo metacognitivo).
Escluse queste due ultime
le altre modalità si prestano ad essere usate come verifiche sommative,
ma anche iniziali ed in itinere.

|