 |
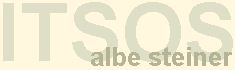 |
 |
|
 |
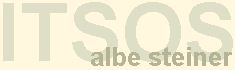 |
 |
|
|
|
IL CURRICOLO DI STORIA CONTEMPORANEA E GEOGRAFIA Una programmazione di storia contemporanea presenta caratteristiche e problemi particolari:
Senza voler ripetere tutto quanto è stato detto sulla “destrutturazione temporale dei giovanì", possiamo sicuramente riconoscere nel cittadino attuale, ed in particolare nei ragazzi, una difficoltà di orientamento anche nel presente. In questo senso una programmazione di storia contemporanea costringe in primo luogo gli insegnanti a chiedersi che cosa significhi oggi possedere e comunicare una coscienza critica, non fondata su ideologie forti, ma su abilità di lettura dei dati e interpretazione delle fonti. Questo significa utilizzare
i mass-media (radio, cinema, televisione, quotidiani, libri) non come fruizione
passiva, che propone spesso un interpretazione preconfezionata, ma con
domande attive, problematizzanti che sono in grado di smontare "gli eventi".
Nell'accezione ideale storia
come comprensione e storia come insieme di soggetto/attivo agente dovrebbero
tornare a coincidere.
1) distinguere fra parti descrittive e parti metodologithe. 2) un habitus di ricerca pronto a scattare di fronte alle scansioni problematiche. 3) Il rigoroso rinvio a pezze d'appoggio per sostenere le proprie tesi. 4) la capacità di lettura e sondaggio delle fonti. 5) la capacità di costruire coerenti argomentazioni senza confondere i piani del discorso. Questo vale sia che il biennio
resti la fase d'avvio della scuola superiore, sia che diventi la fase conclusiva
della scuola dell'obbligo.
Se nella scuola media inferiore i programmi indicano che l'allievo si misuri con sequenze storiche ordinate cronologicamente per arrivare a individuare temi e problemi costituiscono il punto di partenza, adeguatamente contestualizzati questo permette un'operatività più raffinata; il triennio può poi avvicinarsi maggiormente alle questioni anche teoriche poste dalla storiografia attuale. OBIETTIVI E CRITERI DELLA PROPOSTA Alla fine del biennio lo studente dovrebbe possedere alcune abilità di lettura:
a) il modello narrativo non è l'unico nè il più efficace modello di presentazione e di comunicazione dei contenuti al fine di trasmettere la conoscenza di quadri storici generali di ríferiemnto; b) conoscere le strutture e relazioni interne proprie di determinate realtà storiche e conoscere la genesi di queste realtà sono due esigenze cognitive distinte e non necessariamente interdipendenti; c) l'acquisizione e l'uso di categorie temporali non possono essere ridotti allo studio della svolgimento cronologico di fatti collocati nella linea del tempo; d) cogliere il presente come storia, percepire sè stessi come soggetti attivi in una realtà dotata di spessore temporale, in un contesto di persistenze e di mutamenti, sono atteggiamenti e comportamenti che vanno stimolati ed esercitati attraverso una pratica didattica coerente. L'alternativa alla storia generale con taglio cronologico-narrativo può essere cercata in un approccio che: a) definisca una o più ipotesi di lettura di problemì e contraddizioni del presente visti nei loro aspetti di continuità/discontinuità con il passato; b) individui su questa base "casi" che abbiano valore esemplificativo e si prestino allo loro utilizzazione per il raggiungimento di una serie definita e graduata di obiettivi cognitivi e socio-affettivi; c) realizzi un equilibrio tra diverse scale spaziali, diverse durate temporali, diversi tipi di storia; d) colleghi l'approfondimento dei "casi" chiusi con adeguati riferimenti ai quadrì storici complessivi in cui essi si collocano; e) indichi su quali terreni è possibile e necessaria un'integrazione con l'insegnamento di scienze sociali. CARATTERISTICHE
E OBIETTIVI GENERALI DEL BIENNIO: LA NECESSITA' DI UN’AREA STORICO SOCIALE
Un biennio che si ponga come
fascia terminale dell'obbligo a 16 anni comporta una revisione di tutta
la scuola superiore e una riconsiderazione della scuola media:
B) Il biennio deve eessere
unitario, specifico, orientativo, propedeutico. Esso deve rappresentare
il segmento terminale della scuola dell'obbligo con un salto di qualità
che gli permetta di essere ponte per il triennio. L'Area Comune deve
fornire una "formazione culturale di base", contenere cioè "quanto
è necessario che conosca l'individuo nel momento storico dato e
nell'area geo/politica cui appartiene.... indipendentemente dalla specifica
attività che svolge sul piano lavorativo" (M.Corda Costa in "Scuola
Democratica" 1983 n.3-4, pg.36). La funzione orientativa del biennio si
precisa in rapporto ai caratteri di terminalità e propedeuticità
non solo come guida alla scelta di professioni o indirizzi di studio, ma
anche come attività rivolta a favorire le potenzialità individuali
ed a specificare e chiarire le capacità e gli interessi dello studente.
1. unitarietà di un progetto culturale/formativo; 2. un sufficiente equilibrio tra aree culturali in funzione degli obiettivi cognitivi e formativi di ciascuna di esse; 3. una struttura progettuale dell'area comune non riconducibile a mosaico di discipline parcellizzate; 4. la valenza formativa da realizzare attraverso una adeguata scelta e l'impostazione didattica delle discipline dell’area comune e attraverso una ristretta area orientativa che possa anche prevedere opzioni, purchè non condizionanti ma strutturati in senso formativo e metodologico; 5. la ricerca di modalità idonee a rendere più produttiva la scuola nella fase terminale dell’obbligo. In questa direzione ci sembra fondamentale un discorso di aree disciplinari e culturali, che superi una mera giusta opposizione e un allienamento di disciplìne. Questo perchè dobrebbero diventare patrimonio anche delle superiori una revisione epistemologica e una riflessione sulle discipline per indagarne la struttura, i modi specifici in cui contribuiscono a strutturare il sapere e il pensiero, la loro valenza formativa, la contiguità/sovrapposizione di categorie, metodi e campi di indagine. STORIA
, GEOGRAFIA, SCIENZE SOCIALI NEL CURRICULUM
Per quanto riguarda Storia
pensiamo che tutti i processi di revisione epistemo logica e storiografica
vadano nel senso di farne un'area specifica, l'area delle scienze storico/sociali.
Se ciò viene riconosciuto a livello dei nuovi programmi della scuola elementare (dove si parla di uno specifico curriculum di educazione temporale), non si capisce come mai lo si debba negare alle superiori dove semmai è più forte la richiesta di una specializzazione disciplinare. Messa in crisi la concezione della Storia come momento dello Spirito unico irripetibile e quindi non indagabile, riconosciutone ormai, dalle "Annales" in poi, il carattere di scienza sociale (di scienza che indaga con proprie metodologie, parzialmente abbinabili a quelle che stanno alla base di ogni indagine scientifica, come ad es. classificazione, inferenze, ipotesi, modelli di spiegazione), superata la distinzione fra storia (ciò che è realmente accaduto) e storiografia (la ricostruzione intellettuale), vogliamo prendere atto che la disciplina storica ha propri metodi, strumenti, campi tematici che la portano semmai ad incrociarsi con altre scienze sociali (economia, demografia, sociologìa, statistica, geografia antropica) e non ad Italiano? A meno che non si ritenga che basti parlare di “dimensione storica della letteratura" per inventare gemellaggi negati da chiunque conosca la disciplina storica e le scienze del linguaggio. "Introdurre come area a se
stante quella storico/sociale significa interrompere il tradizionale (e
oggi non più sostenibile) abbinamento delle discipline storiche
con quelle linguistico-letterarie (con la conseguente contrapposizione
tra cultura umanistico-letteraria e cultura sceintifico-matematico-naturalistica)
e rivendicare una valenza scientifica non solo alla matematica e alle scienze
della natura, ma anche e distintamente alle discipline linguistico-espressive
e a quelle storico-socialì, evidenziando il ruolo che oggi va assegnato,
nella formazione di base comune a tutti, alle scienze sociali " (relazione
Palmerì in "Il Biennio nella Scuola Secondaria Superiore", IRRSAE
Lombardia-Mursia 1988, pg.45).
Possiamo quindi dire che
rivendicare un’area storico-sociale, cosa che fra l'altro molte scuole
sperimentali praticano da tempo, appare come una delle più importanti
innovazioni da Gentile in poi. Questa innovazione è il segnale
che all'impronta culturale tradizionale di tipo umanistico, rivolta per
lo più ad una esercitazione retorica sul passato, si vuole sostituire
un impianto culturale nuovo a definire il quale concorrono più aree
disciplinari. Solo la presenza di più assi culturali può
infatti garantire una strumentazìone adeguata per capire il presente
senza appiattirsi su di esso e per conoscere il passato in una prospettiva
critica.
LE RAGIONI
DELLA STORIA CONTEMPORANEA.
Ribadiamo che questa programmazione
vuole essere un contributo, in quanto scuola sperimentale che si rinnova
nelle strutture e nelle ipotesi culturali, al dibattito aperto sul ruolo
della storia e delle scienze sociali nel biennio.
In questo senso infatti si
è espresso il M.P.I. Mattarella nella sede del convegno Educazione
alla Mondialità a Milano nell’autunno '89, invitando a fare entrare
nella scuola nuovi modelli culturali che nascano dalle mutate realtà
sociali, per diminuire il divario sempre crescente tra scuola e società.
Si deve creare quindi nuova cultura e conoscenza partendo dalle trasformazioni
in atto che hanno carattere strutturale (la nascita per esempio di società
multietniche, di problemi legati alla convivenza di storie e culture diverse
che necessariamente portano a riconsiderare il senso stesso della storia
non più confinabile in angustie regionali e nazionali).
Poiché non esiste un testo e dei testi di storia e geografia che permettano un percorso flessibile e adatto al raggiungimento degli obiettivi, che consideriamo centrali nell'ottica di un biennio unitario, abbiamo costruito tanti testi monografici, prendendo e assemblando materiali diversi fino a costruire un libro funzionale alla programmazione. Questo permette un'adeguata varietà e graduazione dì materiali o anche di abbinare tutte le volte che lo si ritenga opportuno esercitazioni didattiche di vario tipo per rendere il lavoro operativo e costruire abilità storiografiche. Inoltre quando sia possibile facciamo ricorso anche ad altri media (films, video, quotidiani, riviste) considerando che oggi gli strumenti di un apprendimento storico non passano solo attraverso il libro di testa. Infine il nostro lavoro è volto a far considerare il materiale fornito come un vero e proprio libro che gli studenti devono saper manipolare e gestire. In base a questa premessa,
la programmazione di storia e geografia dando esecuzione alle linee di
revisione già illustrate (vedi allegato), nell'ottica della costruzione
di un'area storico/sociale aventi le finalità e gli obiettivi anche
essi già enunciati, si articola in quattro unità di lavoro
per ogni anno (4 per il secondo).
PERCHÉ
L'AREA STORICO/SOCIALE?
Nel momento in cui si va al rinnovo del progetto per l'intera scuola ci sembra utile proporre alcune ragioni per la costruzione di quest'area in modo integrato nel biennio e nel triennio. In questo ultimo decennio ci sembra sia maggioritaria la figura dello studente prima, del cittadino poi senza "sapere sociale". Ad una fase di “ideologizzazione" di tutti i dati della realtà, ne è seguita un'altra caratterizzata da una parcellizzazione e specializzazione dei "linguaggi" e dei saperi assunti solo nella loro valenza tecnicista. Ci sembra che anche i progetti di riforma ministeriale vadano nella direzione di dare nel migliore dei casi somma si saperi parziali, rinunciando a geni ipotesi di formazione critica, per creare figure non professionalizzante ma funzionari ad una richiesta polivalente "tecnicista" ed "efficientista". Figure cioè che gestiscano un sapere tecnico ma non sociale, separato dal momento decisionale ed estranee alle finalità delle tecniche che maneggiano. Di questi saperi con c'è il "collante" rappresentato da un soggetto che cresce contemporaneamente nei processi di conoscenza e nella sua capacità di costruire una visione del mondo, in grado di riconoscere i meccanismi sociali e produttivi che orientano le scelte tecniche. Questo scollamento ci sembra porti da una parte all'affermarsi di una tipologia e di un movimento degli studenti sempre più "marginale" alla società e che di questa marginalità ed estraneità fa il suo contenuto centrale e dall'altra ad una scuola sempre più svuotata di significati sia per insegnanti che per studenti in cui è sempre più labile riconoscersi un ruolo e sempre più difficile trovare sia valori che conoscenza intesa come indagine critica, come capacità di problematizzare. Si ignorano inoltre tutti i bisogni formativi propri di questa fascia d'età che attraversa tutta l'adolescenza e vede il porsi di domande centrali sul proprio essere individuale e sociale. Stranamente l'aspetto formativo della scuola sembra debba arrestarsi alla soglia della scuola superiore i cui insegnanti si sentono esonerati dal possedere queste competenze. L'area storico sociale dovrebbe
costruire questo passaggio offrendo una proposta culturale e metodologica
che aiuti a conoscere ed agire meccanismi della vita associata a partire
da quelli più immediati come il gruppo classe e la scuola à
quelli più generali, ad orientarsi nella realtà sociale ed
economica, a capire i principali fenomeni in cui siamo immersi e che contribuiscono
a creare la propria identità, a cogliere la dimensione storica in
cui si svolge la vota individuale, a costruire categorie interpretative
sempre più complesse e staccate da identificazioni stereotipe, meccanicistiche
e indette dai vissuti famigliari e sociali più immediati.
Una proposta che aiuti a costruire una visione del mondo come punto d'incrocio
della capacità di usare strumenti d'analisi "scientifici", di maneggiare
modelli interpretativi ma anche di prendere posizione, di riconoscere il
carattere l'orientato" di ogni punto di vista, la capacità cioè
di fondere osservazione empirica, modelli interpretativi, teorie. Una proposta
che riduca lo "scarto" tra "cultura" dello studente e "cultura" della scuola,
che riduca l'appiattimento temporale di cui in genere gli studenti sono
portatori per dialettizzare passato e presente.
Non è quindi auspicabile andare a un rinnovo del progetto in cui
le discipline continuino a svolgere una funzione separata e il centro del
dibattito sia sul numero delle ore da assegnare a ciascuna materia senza
che si discuta qua le figura terminale si vuole creare, che cosa voglia
dire conoscere e usare linguaggi in modo critico. Non c'è nessun
accenno a un discorso di saperi integrati mentre la tendenziale riduzione
di un'area comune porta a privilegiare solo la parte applicativa della
conoscenza.
CLASSI
PRIME. QUESTIONARIO DI INGRESSO
1. ATTEGGIAMENTO. 1.1. Scegli tra queste definizioni di storia quella che condividi di più: a) la storia
è narrazione degli eventi passati della vita degli uomini.
1.2. Consideri la storia
una disciplina:
1.3. Quale periodo, quale processo, quale avvenimento storico ti interessano di più? 1.4. Quale periodo storico tra quelli che hai studiato ti interesserebbe riprendere al biennio? 1.5 Nel
tuo ambiente familiare senti parlare prevalentemente di argomenti storici
2. METODI
2. l. I tuoi strumenti di lavoro nella c-cuda media sono stati prevalentemente (due scelte)
2.2. Le tue esperienze di
lavoro sono state (due scelte)
3. ABILITA' TEMPORALI
3.1. Durate Quanto dura l'impero Romano?
3.2. Anteriorità e posteriorità: delle seguenti coppie chi viene prima e chi dopo? guerre persiane/guerra di
Troia
3.3. Periodizzazione Indica il nome e la durata dei periodi in cui gli storici tradizionalmente dividono la storia. 3.4. Cronologie Fai corrispondere alle seguenti
informazioni la cronologia corrispondente:
4. SPAZIO 4.1. Fai corrispondere al
dato storico, Impero Romano, le aree geografiche corrispettive
4.2. Fai corrispondere ai
seguenti avvenimenti lo spazio corrispondente:
5. METODO STORICO 5.1. Elenca almeno tre scienze che possono aiutare il lavoro dello storico: 5.2. Quali sono secondo te
le fonti per ricostruire:
6. CONCETTI 6.1 Def'inisci:
7. CAUSE 7.1. Dato come causa l'evento
A quale evento B è una conseguenza possibile e immediata?
7.2 Collega con delle frecce
le cause B indicate a destra con le loro conseguenze A elencate a sinistra:
A il prezzo scende
B la quantità di merce richiesta diminuisce
A1 il prezzo
rimane invariato B1 la quantità
di merce richiesta aumenta
A2 il prezzo aumenta B2 la quantità di merce richiesta rimane uguale
QUESTIONARIO FINALE PER IL BIENNIO. Dai una definizione di storia alla luce del programma di geostoria svolto nel biennio. Giudìchi il programma
svolto:
Quale argomento svolto ti ha interessato di più? Perchè? Il programma svolto ti ha aiutato a comprendere meglio alcuni problemi della realtà attuale? Se sì fai degli esempi. Se no, spiega il perchè. Questo programma ha modificato i tuoi atteggiamenti rispetto a:
- rapporto con i mezzi dì informazione
Ritieni che questo programma abbia contribuito a mutare tuoi giudizi precedenti su alcuni argomenti trattati ? Quali osservazioni critiche ritieni di poter fare sul programma svolto riguardo a :
- metodo di lavoro
Quali proposte sugli stessi punti della domanda precedente? Con quali altr discipline tu ritieni che l'insegnamento della storia possa realizzare proficui collegamenti? Cosa ne pensi dell'uso di films come materiale didattico per la storia? Cosa ti aspetti dall'insegnamento della storia? |